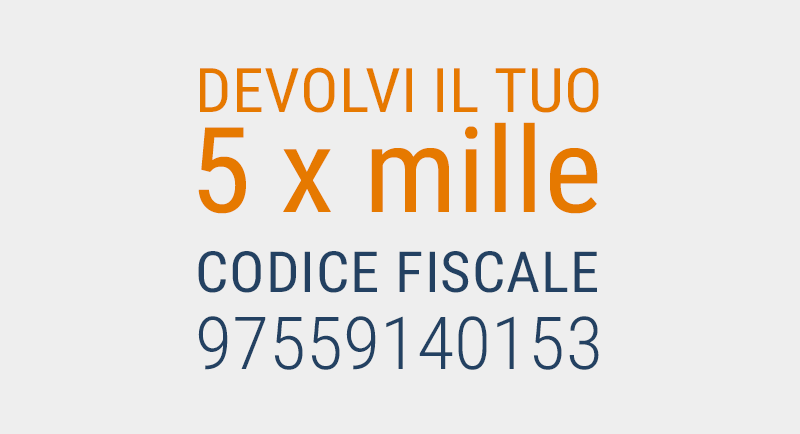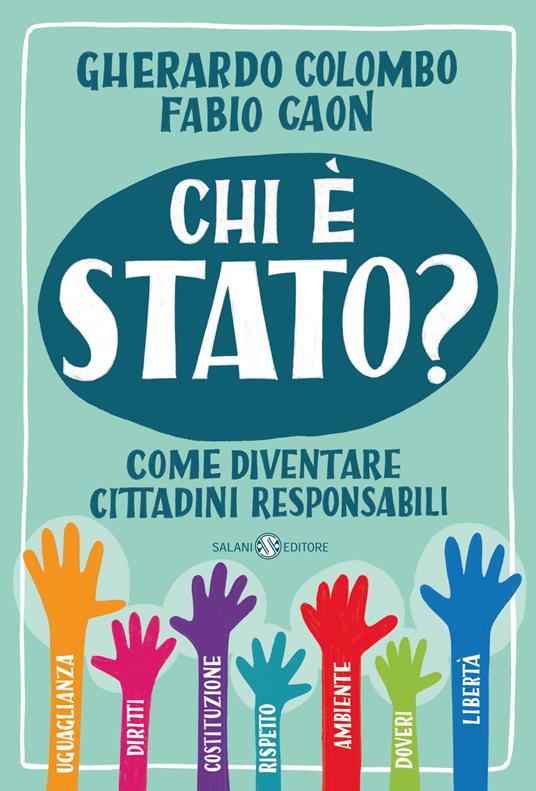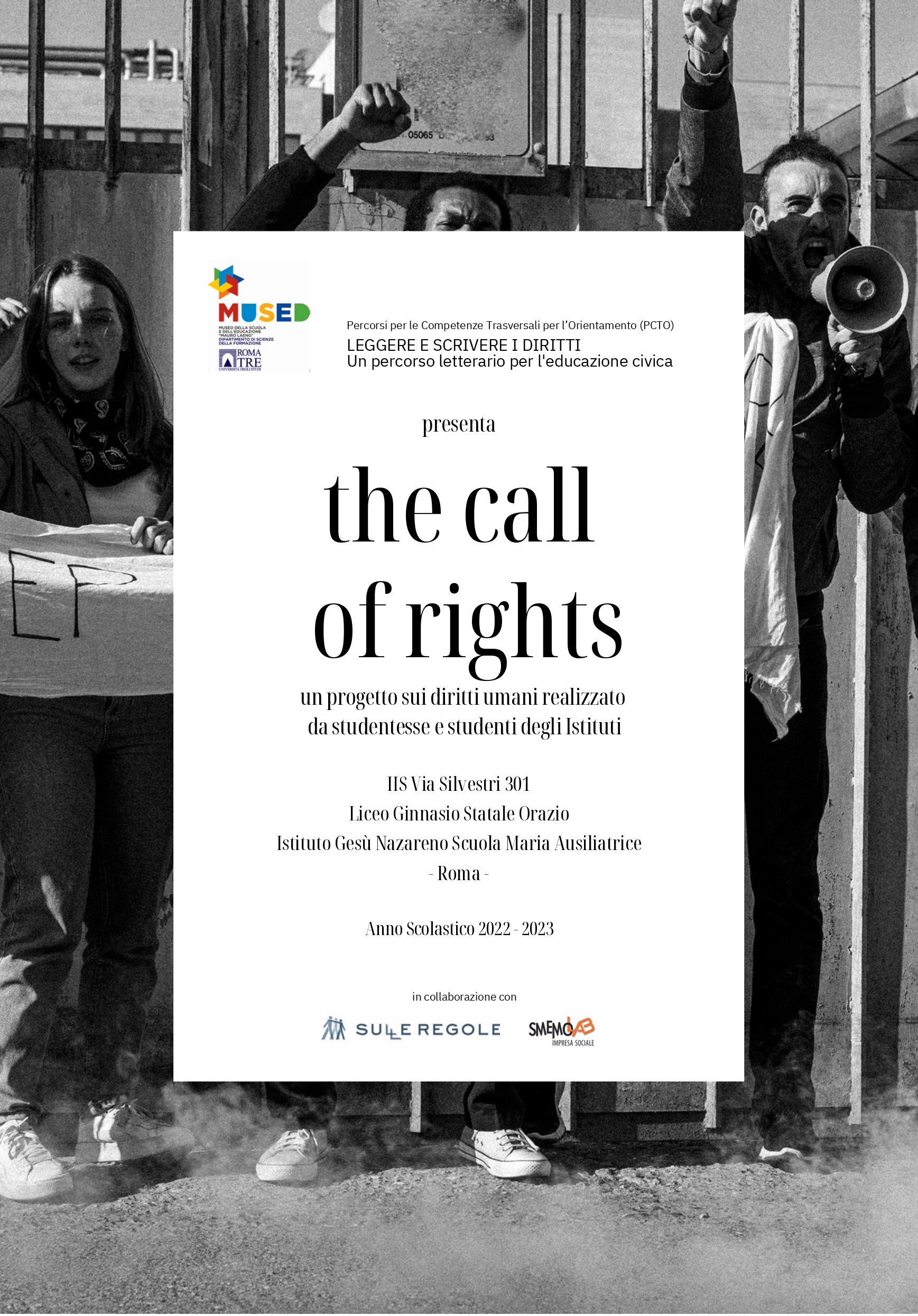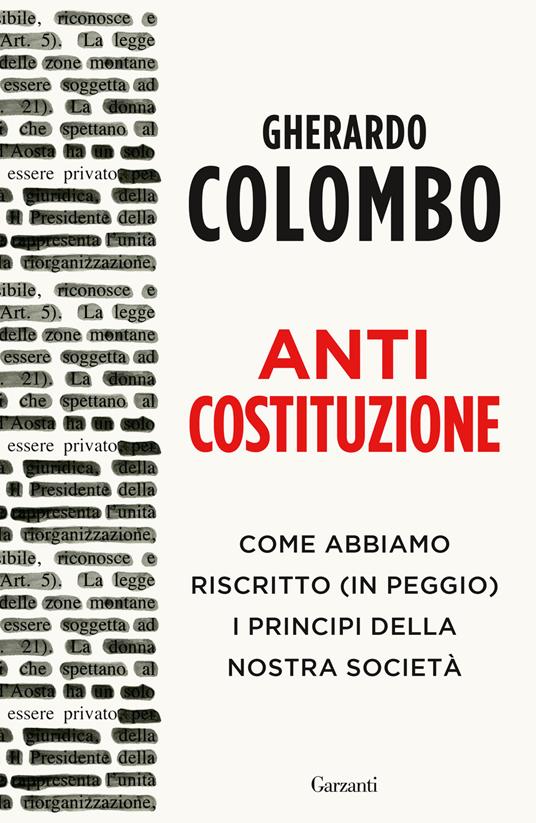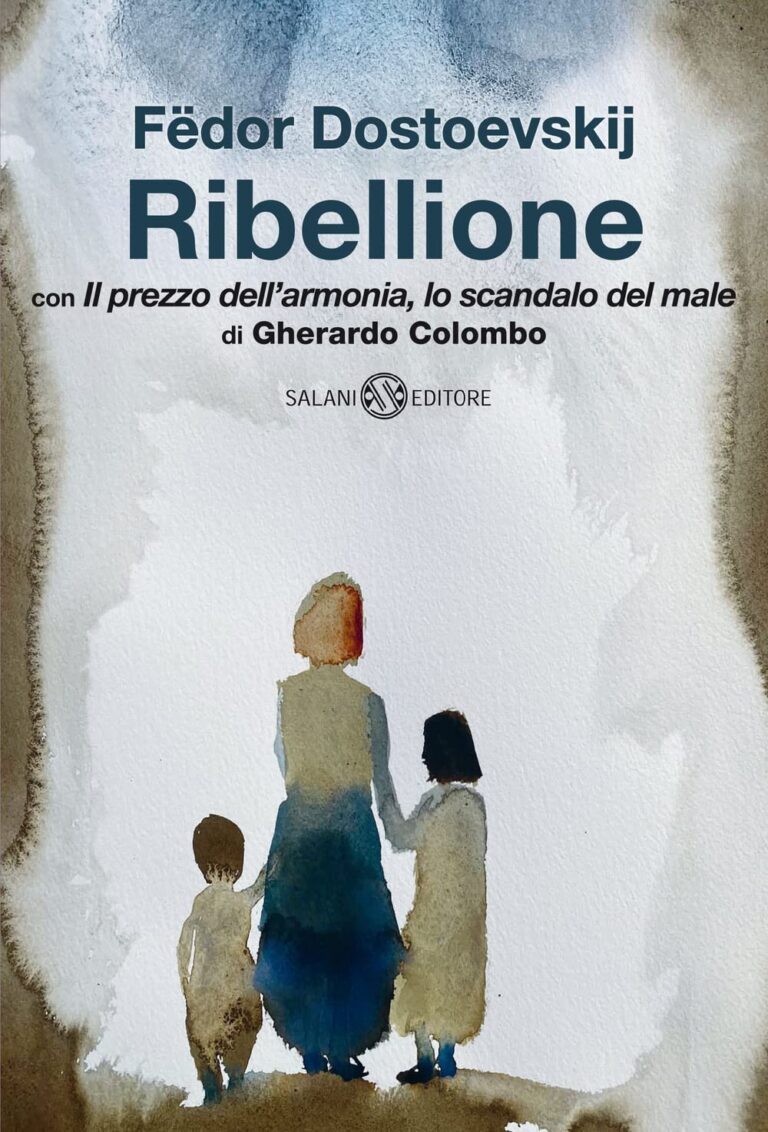USA, 2016
127 min.
Stati Uniti, Virginia, anni ’60. Chi ha la pelle nera vive ancora separato dai bianchi, per legge. Tre amiche scienziate di origine afroamericana lavorano alla NASA, l’agenzia governativa che si occupa dei programmi aerospaziali, impegnata in quegli anni nella corsa per la conquista dello spazio e della Luna, in costante competizione, simbolica e politica, con l’Unione Sovietica. Anche alla NASA non ci sono deroghe: le donne nere sono confinate in un edificio a parte, hanno i loro servizi igienici, sono considerate forza lavoro docile e flessibile. Lucide, coraggiose e determinate, le tre amiche si batteranno contro le discriminazioni che subiscono quotidianamente, ognuna a proprio modo, riuscendo a demolire pregiudizi e barriere razziali.
Un film sul razzismo, anzi, in questo caso sulla “storia del razzismo”, non è mai fuori tempo massimo (come del resto i film sulla shoah, che ci vengono riproposti annualmente, in occasione della Giornata della Memoria). Per la costruzione di società davvero democratiche è necessario continuamente diffondere gli antidoti contro gli istinti più primitivi e tribali dell’essere umano. Il diverso, lo straniero, l’altro ci porta sempre a confrontarci con la nostra intelligenza, la nostra ignoranza, i nostri fantasmi, le nostre paure. Per questo il rapporto con l’altro, qualsiasi altro (anche nostro fratello) è sempre impegnativo e fondato sulla responsabilità etica.
Uno dei rischi dell’accoglienza e della tolleranza, per come attraversano i discorsi pubblici e massmediatici, è che siano sempre “strumentali”, se l’altro ci è utile perché ci arricchisce e soddisfa i nostri bisogni. Ma l’altro esiste a prescindere da noi stessi, e ha la dignità di essere umano prima di ogni nostro giudizio, opinione, posizione.
La Costituzione – che andrebbe insegnata dal primo giorno di scuola, insieme a leggere, scrivere e contare – sancisce la libertà di pensiero, ma non per questo ogni opinione è legittima, se nega i diritti altrui. Di conseguenza le derive razziste e discriminatorie non sono ammissibili, nelle nostre società “democratiche” e in un mondo ormai globalizzato, in cui il “melting pot” è sempre più il tratto dominante.
Fatta questa dovuta premessa, veniamo al film, basato sulla storia vera, e poco conosciuta, di Katherine Johnson, matematica e fisica afroamericana, che lavorò per la NASA tracciando le traiettorie per il Progetto Mercury e la missione Apollo 11, i programmi che consentirono agli Stati Uniti di raggiungere il suolo lunare, nel 1969.
Quella di Katherine è una vicenda “epica” di emancipazione femminile contro sessismo e razzismo, facendo leva sulle proprie forze, competenze e ideali. L’ostinazione e la caparbietà messe in campo dalla protagonista, per rivendicare i diritti civili, e quindi per un mondo più giusto e rispettoso, sono esemplari e contagiose.
Così come è esemplare la figura maschile che dirige il programma spaziale, Al Harrison, il quale, grazie ad una mente aperta e alla disponibilità d’animo, si rende conto dell’assurdità della segregazione e, dall’alto della sua autorità formale, contribuisce ad abbattere le regole discriminatorie che definiscono gli spazi di lavoro. Anche se non scompare il lato d’ombra della vicenda: la scienziata nera viene riconosciuta e trattata alla pari perché “serve” per raggiungere un obiettivo comune più ampio: il successo della missione spaziale.
Tra le sequenze del film di maggiore impatto, segnaliamo, ad esempio, quella in cui la scienziata, esausta e al limite della sopportazione, esplode denunciando pubblicamente la follia e la fatica disumana dei veri e propri viaggi che deve ogni volta affrontare per soddisfare i propri bisogni fisiologici più elementari, nell’unica toilette riservata ai “colored”, collocata in un altro edificio del comprensorio, non proprio a due passi.
Il personaggio di Katherine emerge come quello di una eroina che incarna i valori della resistenza e della dignità umana: nella sfida col suo diretto superiore, un ingegnere servile e conformista, sottomesso alle logiche di potere e gerarchiche che ha introiettato, in un ambiente tutto al maschile, la donna avrà la meglio grazie alle proprie capacità, alla dedizione e precisione con cui esegue i compiti assegnati, alla consapevolezza e stima di sé che le consentono di affermare la propria posizione, sostenuta dall’incontrovertibilità delle regole matematiche e dalla razionalità strumentale del pensiero scientifico. Gli apprezzamenti ottenuti sul piano tecnico-professionale hanno un evidente riflesso a livello sociale: i colleghi cominciano a rendersi conto delle contraddizioni – relativamente alle leggi di natura – insite nel dispositivo della segregazione razziale. Si innescano pertanto dinamiche relazionali di reciproco riconoscimento e cooperazione, foriere di interdipendenza e integrazione sociale: fenomeni che, proiettati su più ampia scala, porteranno, in quegli anni di grande progresso scientifico e cambiamento culturale, all’inevitabile riconoscimento formale della parità dei diritti, indipendentemente dall’etnia e da altri attributi personali.
Altrettanto esemplari in questa direzione, nel corso della narrazione, sono i percorsi delle due amiche di Katherine, Dorothy e Mary. Dorothy riuscirà ad apprendere autonomamente come far funzionare e gestire i nuovi calcolatori elettronici introdotti alla NASA, trovando, con notevoli capacità creative e di problem solving, anche il modo di ricollocare il suo team (di donne afroamericane), che prima eseguiva i calcoli manualmente, ora a rischio di disoccupazione. Mary invece giungerà con tenacia e abilità dialettiche ad ottenere dalle autorità locali la possibilità di frequentare i corsi per diventare ingegnere, realizzando così il suo desiderio.
Intanto sullo sfondo di queste storie personali, si compie la Storia e il sogno di un’intera nazione, e del mondo intero: l’uomo inizia finalmente il suo viaggio nello spazio.
Sappiamo che non esistono film di per sé pedagogici, in quanto il processo educativo si colloca sempre in un rapporto interpersonale intenzionale, ma pellicole come questa, di ottima fattura tecnica ed estetica, possono rappresentare idonei pre-testi, ricchi di spunti per confrontarsi, riflettere e acculturarsi, almeno nei luoghi deputati all’apprendimento e alla crescita, come a scuola o in famiglia. E magari scoprire chi erano e cosa hanno fatto Rosa Parks, Martin Luther King, Malcom X, Nelson Mandela…
Recensione di Alessandro Cafieri tratte da “Conflitti – Rivista di ricerca e formazione psicopedagogica” (www.cppp.it/conflitti).